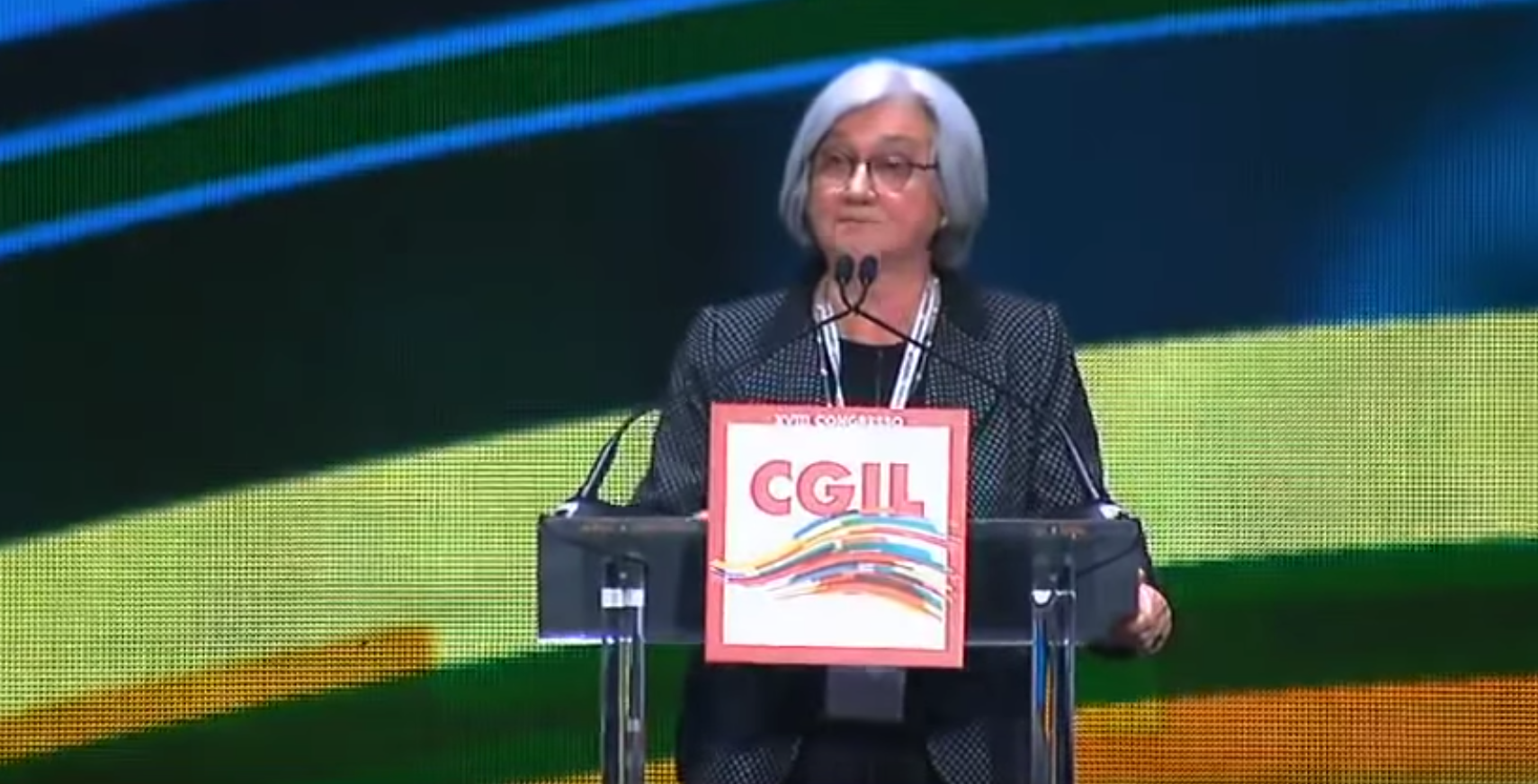Reddito di cittadinanza e piano del lavoro
 di Dino Angelini
di Dino Angelini
Premessa: le prime considerazioni che seguono qui sotto risalgono all’inizio degli anni 2000, cioè a quell’epoca di neoliberismo trionfante che precede la grande crisi economica; e nascono dalla confluenza dentro di me di un insieme di preoccupazioni legate da una parte al mio mestiere di psicoterapeuta, all’epoca responsabile del Consultorio Giovani dell’Ausl di Reggio Emilia, dall’altra al mio sentire di cittadino preoccupato delle conseguenze già allora evidenti del precariato sulla condizione giovanile.
Nel 2002 ero stato invitato ad una serie di conferenze che la Cgil di Reggio Emilia aveva messo in cantiere in occasione del centenario della fondazione della locale Camera del Lavoro, e in quella occasione avevo ascoltato una interessante relazione di Seravalli sulle trasformazioni del mercato del lavoro che confermava ciò che già sapevo: e cioè che negli ultimi 10 anni alla fine del primo anno di lavoro gli occupati a tempo indeterminato erano passati a Reggio Emilia (e non a Reggio Calabria) dal 70% del 1991 al 21% del 2001; ma cercava di fare un’analisi più puntuale, scomponendo gli occupati in base al ‘mestiere’ e al genere ed arrivava a fare un ragionamento più ampio su quella che lui chiamava “la panchina lunga”, che comportava un ingresso procrastinato “in prima squadra” – cioè fra i lavoratori a tempo indeterminato – che col passare degli anni alla fine comprendeva praticamente tutti, e che variava in base – appunto – al comparto ed al genere, con le donne impiegate nei servizi all’ultimo posto.
Il discorso di Seravalli si concludeva più o meno così: se il ciclo economico (come poi puntualmente avvenne) dovesse diventare negativo nei luoghi meno competitivi del mercato globale e negli impieghi più esposti probabilmente si assisterebbe ad una compartimentazione fra i giovani che continuerebbe a vedere da una parte l’uscita, sia pure ‘postuma’, da una condizione di atipicità e di precariato dei più qualificati fra di essi; mentre dall’altra per i meno qualificati, ed in special luogo per gli immigrati e per le donne, il rischio sarebbe quello di una cronicizzazione della loro condizione di atipicità con conseguente progressiva marginalizzazione e svalutazione della loro forza lavoro.
Le considerazioni di Seravalli gettavano nuova luce, e fornivano un fondamento economico a ciò che già da tempo notavo osservando giovani e le loro famiglie nel mio consultorio. Qualcosa che aveva dato origine ad una serie di momenti formativi che avevano visto la partecipazione di oltre 100 colleghi reggiani e non[1]; momenti che alla fine erano confluiti in un testo “Giovani precari. Dall’adolescenza all’età adulta oggi, nell’epoca del precariato e della globalizzazione”, all’interno del quale cercavamo di analizzare ciò che stava accadendo alla nuova gioventù che avevamo sotto gli occhi non più solo in termini economici, ma in termini psico-sociali.
Poi la crisi economica e il persistere nella crisi del flusso migratorio verso l’Europa hanno reso in vario modo più radicali ed urgenti i problemi sociali, lavorativi, familiari ed individuali indotti dalle trasformazioni del mercato del lavoro all’inizio degli anni ’90 del secolo passato.
C’è però un elemento che oggi, dopo la vittoria elettorale del M5S, emerge prepotentemente in primo piano: quello del reddito di cittadinanza, che rappresenta una variabile di tutta una serie di proposte di tipo economico rivolte ai lavoratori, ed ai giovani in particolare, che vorrei affrontare dal mio punto di vista, e cioè in termini psicosociali; proprio come cercai di fare una quindicina di anni fa allorché cominciarono a farsi sentire gli effetti delle leggi volte alla precarizzazione del mondo del lavoro.
Nella conclusioni di quel lavoro, parlando del “salario sociale” o “salario minimo garantito” affermavo:
Penso risulti abbastanza chiaro che in questo quadro occorrerebbe rivedere profondamente concetti  quali il “salario sociale”, il “salario minimo garantito” che a prima vista sembrano delle richieste ragionevoli miranti a garantire il giovane di fronte ad un mercato del lavoro che semina insicurezza e precarietà.
quali il “salario sociale”, il “salario minimo garantito” che a prima vista sembrano delle richieste ragionevoli miranti a garantire il giovane di fronte ad un mercato del lavoro che semina insicurezza e precarietà.
A mio modo di vedere infatti, alla luce di quanto detto sopra, simili proposte, una volta abbandonato l’approccio economicistico di cui sono figlie (Gorz), ed una volta analizzate da un punto di vista psicosociale, rischiano di diventare una vera e propria esegesi di quell’assistenzialismo caritatevole tipico dello stato neoliberista che, nello stesso tempo in cui sbaracca le tutele del welfare che fu, lo fa in nome di un “welfare delle opportunità” che non è che un insieme di interventi-tampone ex post che inchiodano il precario nella sua condizione di colui che ottiene “per preghiera e non per diritto”.
Il che, a mio modo di vedere, in termini psicosociali significa condurre il giovane a considerare il salario sociale come una compensazione assistenzialistica al suo essere nel mondo e, per questa strada: – ad istituire implicitamente di fronte a se stesso la società erogatrice del salario sociale come un’istanza di tutela genitoriale caritatevole; – e, conseguentemente, a vivere se stesso come un perenne bambino bisognoso sempre di tutela e di contenimento.
Il rischio, sempre in termini psicosociali, è la deprivazione della società dell’immenso patrimonio di conoscenze e di creatività rappresentato dai giovani. Infatti la sistematica rinuncia all’istituzione dentro al soggetto neo-adulto di quelle istanze di autonomia e responsabilità che sono le fondamenta dell’età adulta implicano una rinuncia alla progettualità ed, in ultima istanza, un vero e proprio killeraggio del futuro. Laddove invece il lavoro continuativo, attraverso la messa in sicurezza della dignità del giovane adulto, lo garantisce ex ante nella sua autonomia e nella sua capacità di mantenere una propria personale visione del mondo e di assumere su di sé in maniera critica l’etica del lavoro prevalente nella società in cui gli tocca di vivere.
Ora so che il “reddito di cittadinanza” non è proprio la stessa cosa del “salario sociale”, e soprattutto so, per averlo letto di recente in una intervista a Tridico, cioè a colui che è il ministro del lavoro in pectore del M5S, che si tratterebbe di una misura di breve periodo, che servirebbe solo a far ripartire l’economia. Purtuttavia a mio modo di vedere, nonostante il proposito di legare il reddito di cittadinanza all’accettazione da parte del lavoratore di un percorso di ingresso (o re\ingresso) nel mercato del lavoro, ritengo che il progetto sia criticabile in base a due tipi di considerazioni: innanzitutto perché il provvedimento può dar luogo a risultati opposti rispetto a quelli preconizzati (eterogenesi dei fini); ed in secondo luogo perché il concetto di ‘cittadinanza’ tende a circoscrivere la platea degli aventi diritto solo agli autoctoni.
Sulle peripezie del concetto di cittadinanza ho già detto in: “L’integrazione dei giovani migranti nella città e nei luoghi dell’incontro”, a cui rimando il lettore.
Sull’eterogenesi dei fini, che rischia di trasformare un progetto di breve periodo in un assistenzialismo sine die, vale il fatto che alla fine – come tentavo di dire 15 anni fa – il mantenimento del giovane in uno stato di dipendenza può diventare attraente poiché sedimenta nel tempo una enorme base sociale di tipo clientelare che può allettare anche la forza politica più pura di questa Italia.
Di contro o in continuità con misure effettivamente di breve periodo e che comprendano tutti, e non solo i cittadini autoctoni (qui stanno le prime due scommesse che il M5S è chiamato a vincere) – il varo di un piano del lavoro è destinato non solo a reintrodurre i giovani autoctoni ed immigrati all’interno del mercato del lavoro e a rilanciare l’economia, ma anche e soprattutto – almeno dal mio punto di vista – a condurli ad un condizione realmente adulta, autonoma, capace di progettare e progettarsi guardando al futuro come ad un qualcosa di possibile e di raggiungibile sul piano della dignità, e non della sudditanza clientelare o semischiavistica.
 Ai fini del lancio di un piano del lavoro ritengo che gli altri quattro punti di Tridico siano molto interessanti, e che essi non possano essere disgiunti dal ‘reddito di cittadinanza’. Cerco di elencarli:
Ai fini del lancio di un piano del lavoro ritengo che gli altri quattro punti di Tridico siano molto interessanti, e che essi non possano essere disgiunti dal ‘reddito di cittadinanza’. Cerco di elencarli:
- investimenti produttivi dello Stato nei settori a più alto ritorno occupazionale, con il 34% di questi investimenti nel Sud Italia;
- salario minimo orario;
- Patto di produttività programmato tra lavoratori, governo e imprese al fine di “rilanciare salari, produttività e investimenti, soprattutto in quei settori in cui decideremo di intervenire selettivamente, ed abbandono degli sgravi fiscali sulle nuove assunzioni regalati dal Jobs Act”;
ed infine 4. “il tema di più lungo periodo della robotizzazione, una sfida che non va lasciata alla schizofrenia del mercato, ma gestita politicamente, ed in primo luogo con la riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario, in modo da aumentare l’occupazione e di incentivare la riorganizzazione produttiva delle imprese”.
Su questo piano mi limito a segnalare, da cittadino, alcuni progetti strategici già abbozzati e, direi, a disposizione di quei governanti che abbiano orecchie per intendere:
- Il progetto di Gino Strada per la sanità italiana;
- Il piano Settis per l’ambiente;
- Il progetto Archimede di Rubbia per sostituire l’energia basata sul petrolio con il solare
- Il progetto Piano per le zone terremotate;
- il progetto della Gabanelli per i migranti;
- Il progetto di rilancio del Sud, di Canesi e Del Monaco.
Ai quali aggiungerei una riforma del ‘sociale’ che tenda ad evitare la formazione di oligopoli e premi il merito, mettendo nel contempo fuori gioco sia gli accordi di cartello che conducono ad una falsa selezione al massimo ribasso, come avviene oggi, sia le burocrazie d’area che imperano parassitariamente e creano generazioni di operatori precari, sottopagati, scarsamente formati e assunti in base non al merito ma all’appartenenza clientelare.
[1] Ora racchiusi nel testo, “L’adolescenza nell’epoca della globalizzazione”