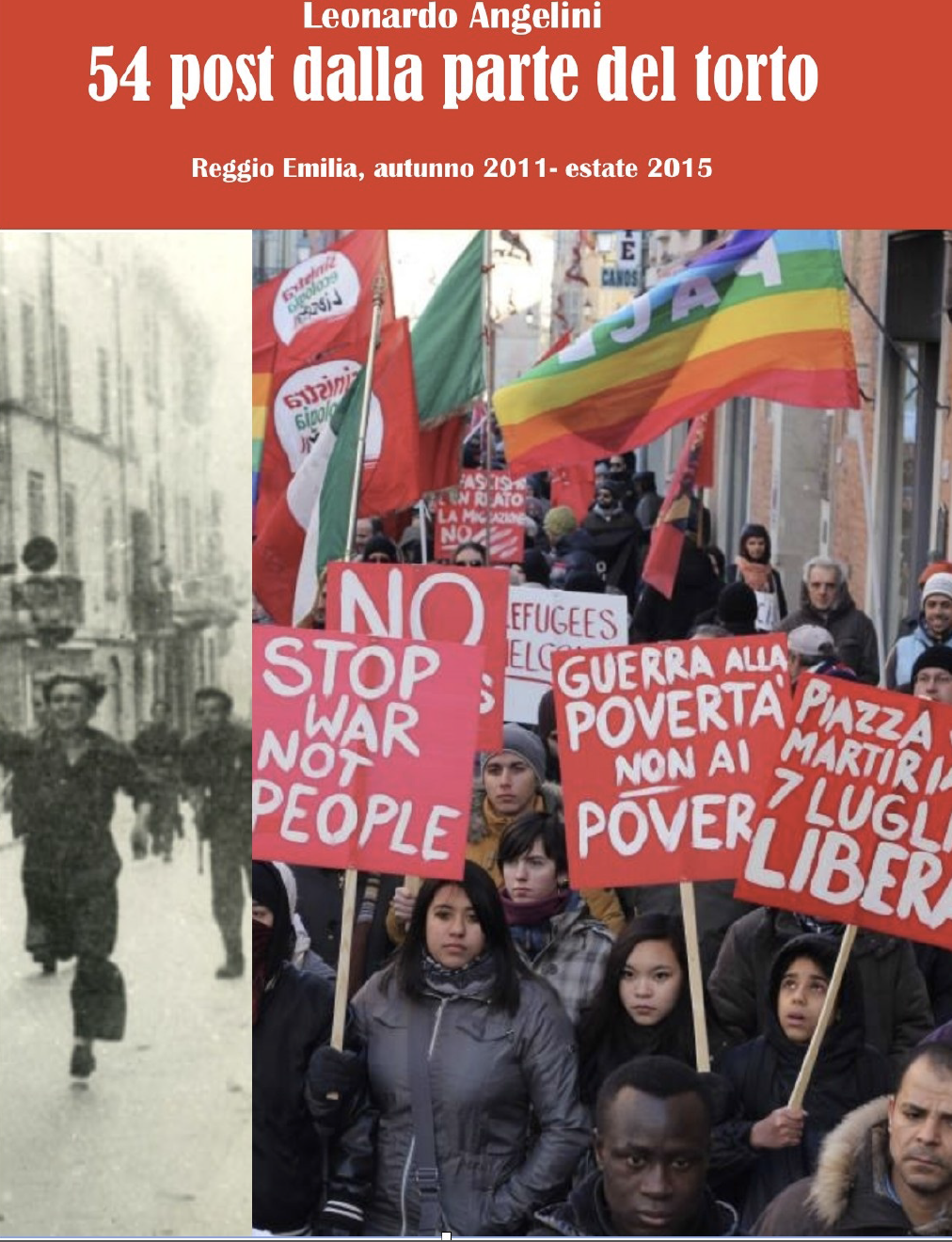Il lavoro improduttivo
Dino Angelini
1.11.12
 Intorno al ’92 – ’93, a Santoro che lo interrogava su come in Europa vedevano il welfare italiano, Vizzini (ministro di uno degli ultimi governi della prima repubblica) rispondeva più o meno così: “Ci chiedono quand’è che ci decideremo a fare in modo che il welfare passi dal capitolo delle spese a quello delle entrate”.
Intorno al ’92 – ’93, a Santoro che lo interrogava su come in Europa vedevano il welfare italiano, Vizzini (ministro di uno degli ultimi governi della prima repubblica) rispondeva più o meno così: “Ci chiedono quand’è che ci decideremo a fare in modo che il welfare passi dal capitolo delle spese a quello delle entrate”.
Seguirono le prime aziendalizzazioni (De Lorenzo!) e, nella seconda repubblica, un’opzione bipartisan che tendeva sempre più inesorabilmente a generalizzare esternalizzazioni, aziendalizzazioni, formazione di partecipate etc.. e a promuovere la dismissione di intere porzioni di welfare che in questo modo passavano dalla spesa pubblica a quella delle famiglie: si pensi all’inabissamento della cura degli anziani e all’esplosione del fenomeno delle badanti.
Tutto il processo però fu fatto all’italiana. E cioè sistemando in questi nuovi luoghi della cura questo o quel cliente “meritevole”, dando ampio spazio alla chiesa e soprattutto guardandosi bene dall’esercitare funzioni di controllo della qualità e della reale utilità sociale dei servizi erogati. All’inizio il tutto ci fu venduto come un’esigenza di risparmio: sul personale che diventava precario, sulle spese per la formazione che venivano scaricate sui singoli lavoratori e su quelle una volta erogate in direzione dei servizi del vecchio welfare universalistico, che così piano piano veniva svuotato di funzioni e di risorse.
In seguito vennero i ticket, l’aumento del prelievo fiscale che lo stato centrale passava col contagocce agli enti locali, la nascita di pachidermi privati, semiprivati o partecipati costosissimi e assolutamente non gratuiti. Insomma c’è stato, come ci chiedeva l’Europa, un travaso del welfare dal capitolo delle spese a quello delle entrate; e come imponevano i partiti la nascita di un welfare privato, costoso, clericaleggiante, gonfiato oltremodo dalle clientele, centrato sul lavoro precario sottopagato e sull’inabissamento di quote crescenti di cura che cominciarono sempre più a pesare sulle singole famiglie, e sulle donne in particolare.
Cerchiamo ora di capire cosa è accaduto nel passaggio dal vecchio al nuovo welfare dal punto di vista degli operatori e da quello dei fruitori. Ieri i vecchi operatori del welfare gratuito e universalistico erano improduttivi, cioè non creavano plusvalore, ma da una parte erano necessari in quanto contribuivano alla riproduzione della società attraverso l’erogazione di servizi gratuiti di cura e di tutela (si pensi agli insegnanti della scuola pubblica, ai medici operanti negli ospedali pubblici, etc.), dall’altra diventavano erogatori di un salario indiretto, perciò veicoli di ridistribuzione della ricchezza.
Oggi, invece, i nuovi operatori sono produttivi, poiché almeno a prima vista operano in imprese che mirano a massimizzare gli utili e che perciò si collocano nel capitolo delle entrate. Ma a ben vedere subito le cose si complicano perché da una parte ieri – almeno in Italia – il vecchio welfare si è sempre biforcato in welfare dei servizi e welfare dei sussidi che, al contrario del primo, spesso più che contribuire alla cura e alla tutela distribuiva le risorse “a pioggia” in direzione individuale e clientelare.
Dall’altra le aziende del nuovo welfare difficilmente operano secondo criteri realmente aziendali: più spesso sono sussidiate attraverso mille rivoli dai contributi pubblici, cioè dal denaro di chi paga le tasse. Per cui diventano aziende sostanzialmente improduttive, solo artificiosamente definibili come necessarie (si pensi agli scandali della sanità lombarda).
Il tutto, prima e dopo, è reso vieppiù squilibrato dall’enorme evasione fiscale che, oggi come ieri (ma più di ieri), produce l’effetto perverso di scaricare le spese del welfare solo sulle spalle dei lavoratori dipendenti: una redistribuzione a rovescio a tutto vantaggio degli evasori che chiede vendetta (!) ma che nei fatti non muove alcuna forza politica, poiché tutti o quasi tutti i partiti sono arroccati dietro i loro manager e – come dicono quelli di Cortocircuito – i loro “riciclati” che garantiscono il consenso e i voti dei ricattabilissimi precari che affollano le loro pseudo-aziende.
Andiamoci a rivedere le puntate della Gabanelli sugli ospedali italiani e sulle logiche di subappalto che imperano in essi, con filiere che partono dai magnati della sanità per giungere fino alla microimpresa che assume (sempre a tempo determinato!) l’ultimo portantino, per rendersi conto del perché degli sprechi ma anche del perché nessuno si ribella a questo andazzo.
L’attuale Europa delle banche, erede vittoriosa di quella che già all’inizio degli anni ’90 ci chiedeva di privatizzare tutto, invita i governi a grattare il fondo del barile e a terminare l’opera col plauso di quasi tutte le forze politiche. Il che, di fronte alla crisi, significa lasciare sul campo morti e feriti destinati a diventare poi oggetto di cure compassionevoli.
Ciò vale per il welfare ma anche per i beni comuni, di cui il welfare potrebbe essere parte se si ricollocasse come lavoro improduttivo ma necessario alla riproduzione sociale. Nel perseguire quest’obiettivo a mio avviso occorrerebbe coniugare la difesa a livello “locale” (e cioè aziendale, di settore) dei diritti con un pensiero e un’azione collettiva, continentale direi, volta a trasformare l’Europa delle banche in Europa del lavoro.