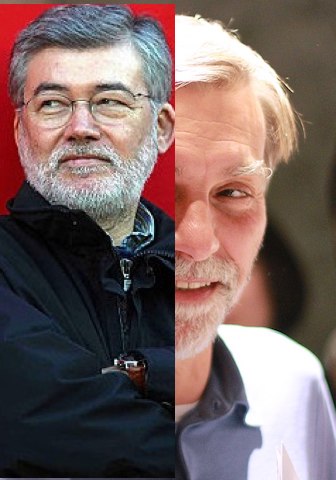Le femministe e il welfare
Dino Angelini
19.5.12
 Quando gli economisti guardano al welfare considerano prevalentemente i suoi aspetti quantitativi: il welfare ai loro occhi appare come uno strumento di redistribuzione del reddito volto a rendere effettiva l’estensione dell’area dei diritti e delle tutele agli strati sociali più deboli, come previsto dalla nostra Costituzione.
Quando gli economisti guardano al welfare considerano prevalentemente i suoi aspetti quantitativi: il welfare ai loro occhi appare come uno strumento di redistribuzione del reddito volto a rendere effettiva l’estensione dell’area dei diritti e delle tutele agli strati sociali più deboli, come previsto dalla nostra Costituzione.
Se però noi passiamo dal piano quantitativo a quello qualitativo le cose appaiono in maniera alquanto diversa, poiché la riflessione sulla qualità del welfare implica l’analisi delle pratiche concrete, dei concreti percorsi di cura che in esso sono in atto e, prima ancora, dei criteri di fondo ai quali le varie pratiche s’ispirano.
Facciamo l’esempio delle strutture prescolari: se io vedo in esse solo il dato quantitativo noto che la loro diffusione permette alle donne di ottenere un salario indiretto derivante dal fatto che l’inserimento del bambino al nido e alla materna consente alla madre di tornare velocemente e a salario pieno sul mercato del lavoro; cosa che “prima” – cioè quando le strutture prescolari non c’erano – non poteva permettersi.
Ciò ovviamente non è cosa di poco conto. Ma se consideriamo queste strutture come luoghi educativi, in cui si definisce nel tempo un’alleanza educativa fra tate e genitori (un maternage multiplo, direbbe un etnologo), noi giungiamo a ben altre conclusioni circa la natura di quei luoghi, che diventano luoghi di sperimentazione in cui tutti gli attori presenti sulla scena risultano più o meno profondamente trasformati dalla partecipazione a queste pratiche.
Pratiche, peraltro, che s’incrociano con punti di vista sul mondo, discipline (nel nostro caso la pedagogia), procedure e protocolli che, a loro volta, nella palestra di una prassi che non rinuncia a pensare a se stessa possono essere confermati, emendati o invalidati. La stessa cosa avviene in ogni altro campo del welfare e così ecco che non solo la pedagogia, ma anche la psicologia, la psichiatria, la medicina, la formazione e finanche il management sono messi in discussione in questo processo, almeno fino a quando le istituzioni del welfare rimangono corpi vivi e disposti a lasciarsi contaminare da ogni entità che entri in rapporto con loro.
Ora, in un’interessante introduzione a una serie di seminari che le femministe milanesi, romane e napoletane vanno facendo da più di un anno sul rapporto fra cura, lavoro e politica, Lea Melandri – una delle madri del femminismo italiano – nella sua riflessione sul welfare “Cura/lavoro: la rivoluzione possibile” afferma fra l’altro: “Ma a distanza di tempo forse è possibile fare un passo ulteriore, abbandonare l’idea che la cura sia soltanto una questione da risolvere con un buon welfare o la monetizzazione dello Stato, e mettere invece al centro quel “resto”, quello “scarto”, che la socializzazione totale, i servizi organizzati e pagati non riescono a cancellare”.
Ebbene a mio avviso ridurre il “buon welfare” alla “monetizzazione dello Stato” significa ridurlo ai suoi aspetti economici e perdere di vista tutto il piano qualitativo sul quale, almeno fino a qualche decennio fa, proprio il movimento femminile e femminista, insieme a molte altre soggettività collettive (movimenti di base, associazioni, operatori e operatrici), avevano detto, fatto e riflettuto.
Prendiamo un altro esempio: quello dei consultori. In questo caso la spinta alla loro istituzione non fu prioritariamente dovuta a motivi di tipo economico. Furono fatte molte battaglie, che videro in prima linea proprio le femministe; ma poi tutte le ragioni ideali che erano state alla base dell’istituzione di quel servizio furono perse per strada, e oggi è troppo facile attribuire alle giovani generazioni lo scarso impegno per togliere il consultorio dal vuoto pneumatico in cui si è ridotto, se non dalle grinfie del Movimento per la vita (come sta avvenendo qui da noi a Correggio).
Va bene: come dice la Melandri c’è effettivamente uno scarto fra ciò che possono dare sul piano della cura le madri e le famiglie rispetto e ciò che danno lo Stato e gli enti locali attraverso il welfare. Ma, aggiungo io, c’è anche uno scarto grande come una casa fra ciò che dà oggi il welfare aziendalizzato e\o clericalizzato (e non, come dice la Melandri, socializzato) e ciò che ogni suo comparto potrebbe dare sul piano della cura se solo i movimenti critici che ormai rinascono dappertutto tornassero a investire, con le loro sensibilità e la loro scienza, sul tessuto ormai logoro di questo vecchio welfare, che anche a Reggio Emilia arretra su tutta la linea.
Intanto, nell’attesa che questa parte torni a investire anima e corpo su di esso, il welfare è sempre più nelle mani dei rottamatori neoliberisti e dei “cesaroli” di ogni parrocchia. Il primo vettore ci porta verso la Grecia; il secondo verso la proliferazione molto democristiana delle clientele.